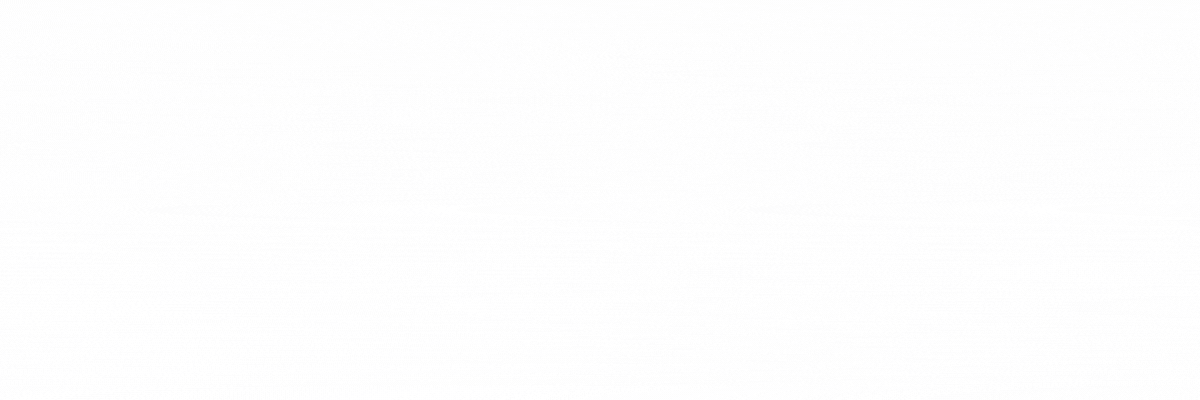di ALCEO LUCIDI
SAN BENEDETTO – Chiude la stagione in prosa del teatro “Concordia” per il 2017 – sulla base di una programma che non abbiamo avuto remore nel definire ferreamente strutturato su titoli indémodables – e lo fa nel migliore dei modi. La Locandiera di Carlo Goldoni – un classico della drammaturgia internazionale, andata in scena martedì 11 e mercoledì 12 aprile – ha convinto per più di una ragione. Innanzitutto, per le chiavi interpretative adottate dal regista Andrea Chiodi nei confronti del testo, soprattutto in termini di caratterizzazione dei soggetti, e, anche, per l’originale resa drammaturgica.
La Locandiera, rappresentata per la prima volta al teatro Sant’Angelo di Venezia il 26 dicembre del 1752, è una pietra miliare delle commedie di costume di ogni tempo, tanto per la compattezza della struttura narrativa, quanto per la solidità, narrativa e psicologica, dei caratteri (non più tipi) ed un vivido realismo dei quadri d’assieme. Anzi – per meglio essere precisi – si pone al vertice di quella “riforma” goldoniana che, avviatasi nel biennio 1750-51, portò il drammaturgo veneziano a firmare un ciclo, insuperato e straordinario, di ben sedici nuove pièces, scritte per la compagnia di Guglielmo Medebach, in qualità di poeta.
Dell’insieme di tale produzione – oltre alla Locandiera spiccano opere come La serva amorosa, Le seve gelose, La donna Vendicativa – nasce un nuovo genere di indagazione e caratterizzazione del reale che muove dalle trasformazioni politiche e culturali del Settecento. Pienamente inserito nel contesto storico di appartenenza, di cui è perfino una chiara ed esaustiva esemplificazione, il tipo di teatro “nuovo” inaugurato da Goldoni, sulla scia di altri modelli francesi (Marivaux, Prévost) e inglesi (Fielding), in effetti, delinea perfettamente i rapporti, sempre più complessi, tra la sonnecchiosa e decadente aristocrazia europea, ferma su sterili prerogative, ed il nuovo ceto borghese, affarista, intraprendente, rampante. In particolare, fotografa bene le dinamiche sociali della sua amata Venezia, con al centro i traffici commerciali verso l’Oriente.
Insomma, tutto si gioca sullo stridente contrasto di valori, mentalità, ideologie che vede nelle contrapposizioni tra il Marchese di Forlimpopoli (un istrionico ed esilarante Tindaro Granata), il Duca di Albafiorita (Caterina Carpio, brava nel vestire i panni di più personaggi), il Cavaliere di Ripafratta (un Emiliano Masala dolce-amaro e sottilmente ironico), da un lato, e Mirandolina (restituita nella smagliante interpretazione di Mariangela Granelli, forzata fino all’acredine) e Fabrizio, suo servitore e futuro marito, dall’altra, il suo punto di equilibrio.
Mirandolina, corteggiata da nobili spiantati che fingono di avere ancora voce in capitolo in un mondo completamente mutato, da affaristi spregiudicati che aspirano ad un altrettanto illusorio statuto nobiliare, da cavalieri male in arnese misogini che cadono alla fine nelle maglie del fascino femminile, è l’esatta espressione di un tipo di società che si muove tra pragmatismo, solerzia, efficientismo imprenditoriale ed una nutrita dote di buon senso. Manipola gli “uomini-clienti” della sua locanda – secondo il critico teatrale Luigi Lunari – e non si contenta più dell’amore-passione svilito, edulcorato, fine a se stesso, ma lo finalizza al matrimonio (e lo sacrifica ad un diverso ordine sociale).
Non basta ad ogni modo. Nella regia di Chiodi risalta un’eleganza, una misura, un’attenzione ai dettagli e, anche, un’originalità di visione veramente particolari. Siamo nel metateatro, con gli attori che dialogano con il loro doppio, rappresentato dalle marionette della scena fissa, retaggio delle poupettes, le bambole dell’infanzia di cui Goldoni parla diffusamente nelle sue Memorie. Si è voluto, in fin dei conti, mettere in risalto, scopertamente, quel formidabile meccanismo teatrale che è la Locandiera, portando i personaggi ad intersecarsi e sovrapporsi, ad uscire dai propri gusci, dagli stereotipi di una Commedia dell’Arte ormai abusata e, del resto, non più in uso ai tempi di Goldoni – come notò nel 1966 Elio Vittorini –, attraverso l’utilizzo di una scena stilizzata dove si muovono pedine – lo denotano anche le sembianze neutre da schermidori in abiti d’epoca degli attori – disposte sullo scacchiere del reticolo testuale.
Il tavolo troneggiante sulla scena, linea diaframmatica che separa un sopra ed un sotto, un detto ed un non-detto, un vuoto ed un pieno dei rapporti umani, è il locus di tutte le, spesso misere, ambizioni sociali, la riproposizione, posticcia, di una caleidoscopica “fiera delle vanità”.