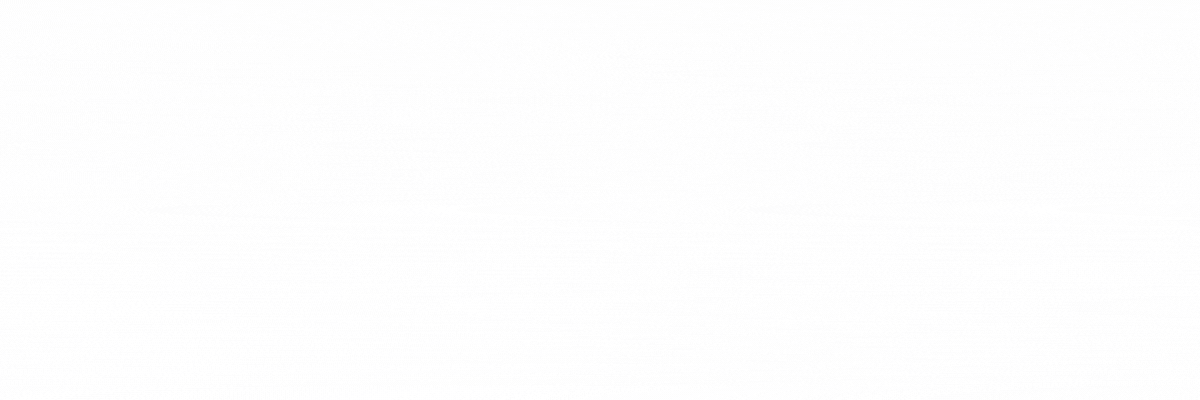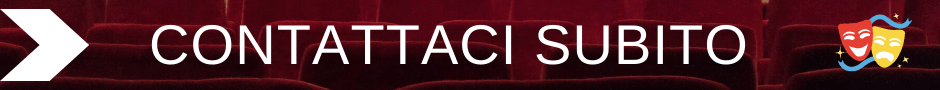di ALCEO LUCIDI
GROTTAMMARE – L’attore e registra teatrale Vincenzo Di Bonaventura (nella foto) rappresenterà in tre distinte serate, domani 10 (ore 21.15) e 24 gennaio e il 7 febbraio, presso il Deep Art di Grottammare, per la sezione “Di Martedì”, prevista nel programma della stagione culturale 2016/17 dell’associazione culturale “Blow Up”, il dramma storico di Rolf Hochhuth Il Vicario, che tanto scalpore suscitò al momento della sua uscita, per la severa critica esercitata contro i silenzi e l’atteggiamento compromissorio dei vertici della Chiesa cattolica rispetto al regime nazista.
Di Bonaventura farà rivivere il corposo testo attraverso una libera (re)interpretazione intensa ed appassionata, dando voce ai diversi personaggi principali – almeno otto – tramite un’operazione di profonda rivisitazione scarnificazione del testo. Un lavoro di gestazione che precede ogni suo adattamento teatrale, in cui Di Bonaventura riunisce con sorprendente maestria – legata alla lunga frequentazione di un teatro totalizzante o della “testimonianza” – la parola al suono e al gesto, rappresi nell’urgenza espressiva.
Pubblicata in Germania nel 1963, la pièce Il Vicario di Rolf Hochhuth, drammaturgo tedesco, classe 1931, suscitò un fortissimo dibattito alla sua prima rappresentazione, il 20 febbraio dello stesso anno, al teatro Fei Volsbuhne, per opera del regista Erwin Piscator. A seguito dell’enorme impatto scaturito dal contenuto di denuncia sociale dell’opera circa i dolorosi ed inspiegabili silenzi della Chiesa Cattolica, ed in particolar modo del suo Vicario, papa Pio XII, sulla deportazione e l’eccidio di milioni di ebrei, le stesse gerarchie ecclesiastiche romane furono costrette a prendere posizione e a riaprire gli archivi vaticani.
Nonostante la profonda eco che il dramma ebbe in tutta Europa, dove venne riproposto più volte, dando vita tanto a riflessioni ed approfondimenti quanto ad un fiorire di studi e trattati, in Italia dell’opera si perse completamente traccia: se si esclude la pubblicazione del libro nel 1964 da parte dell’editore Feltrinelli ed un’audace messinscena clandestina con Carlo Cecchi e Gian Maria Volonté, l’anno successivo, in pieno centro a Roma, con tanto di denunce, scomuniche, scontri di piazza, l’interruzione dello stesso spettacolo e degli strascichi polemici che – seppur circoscritti – spinsero alcuni intellettuali ad entrare nel vivo della querelle.
Del resto, l’opera drammaturgica aveva una forza rievocativa ed un apparato documentario troppo potenti, e quello di Hochhuth fu un tentativo talmente rigoroso di scandagliare, attraverso gli strumenti affinati della finzione teatrale, il contesto politico ed ideologico in cui si consumò l’Olocausto, da non potere non scuotere la pur moralmente irretita società italiana del Dopoguerra. Hochhuth è implacabile nel descrivere i meccanismi psicologici sottesi al folle programma di sterminio nazista, alla manipolazione delle coscienze che ne derivò, al suo lento radicamento nella cultura tedesca degli anni Trenta e Quaranta del XX secolo.
Il suo vuole essere lo spettacolo desolato di una tragedia assoluta in cui l’uomo è divenuto strumento di distruzione e di morte per l’uomo; dove non c’è posto per rivisitazioni di comodo; dove – come ebbe a dire Carlo Bo – il punto focale del discorso viene tenuto puntato sul tema delle responsabilità individuali, lontano da deduzioni pseudo-assolutorie che si leghino ai concetti dell’isteria collettiva e dello sbandamento populista di un intero popolo. Quando il male assume simili proporzioni ogni barriera retorica cade e l’uomo si ritrova solo di fronte allo specchio della propria coscienza.
Sorretto da una robusta rete di fonti storiche, da un folto numero di personaggi altrettanto riconoscibili (dal nunzio apostolico a Berlino, a Padre Riccardo Fontana, rivisitazione di Bernhard Lichtenberg, prevosto della cattedrale di Sant’Edvige in Berlino, elevatosi al sacrificio dei campi di sterminio, da Kurt Gerstein, medico-patologo ed ufficiale delle SS, anch’egli impegnato a strappare quante più vite possibili ai campi di morte, allo stesso Pio XII), l’opera si muove con le movenze di un’epica dell’assurdo, tra dialoghi incalzanti ed un serrato susseguirsi di fatti che ne precipitano la narrazione.
Nel mezzo di tale profluvio verbale, di tale nutrito e sentito J’accuse, ciò che pesa di più è sicuramente il silenzio del capo spirituale di una Chiesa che ha perso ogni funzione di guida e di baluardo contro nefandezze ed abusi, in nome della “legge dell’amore e del bisogno di verità”, anche se a contare, in ultima istanza, sono le inadempienze di chi si è nascosto o ha rinunciato ad intervenire; di chi poteva intercedere e si è astenuto.
Hochhuth con il Vicario vuole ricordarci che il Male molto spesso è in noi, nelle nostre indifferenze ed ipocrisie, nelle mezze parole e nell’inedia a cui sottostiamo e che può anche, se non arginato, prendere forme mostruose, divorando le nostre vite, penetrando nei nostri modi di essere e di pensare, permeando le nostre già fragili personalità.
Il primo, grande merito di Hochhuth è quello di avere risvegliato bruscamente tante menti dal pericoloso sonno della stanchezza spirituale e dalle manipolazioni del tempo, con il preciso intento di impedire che eventi di tale spaventosa brutalità, della cui trattazione si fece dolorosamente carico, finiscano per scivolare nella retorica.