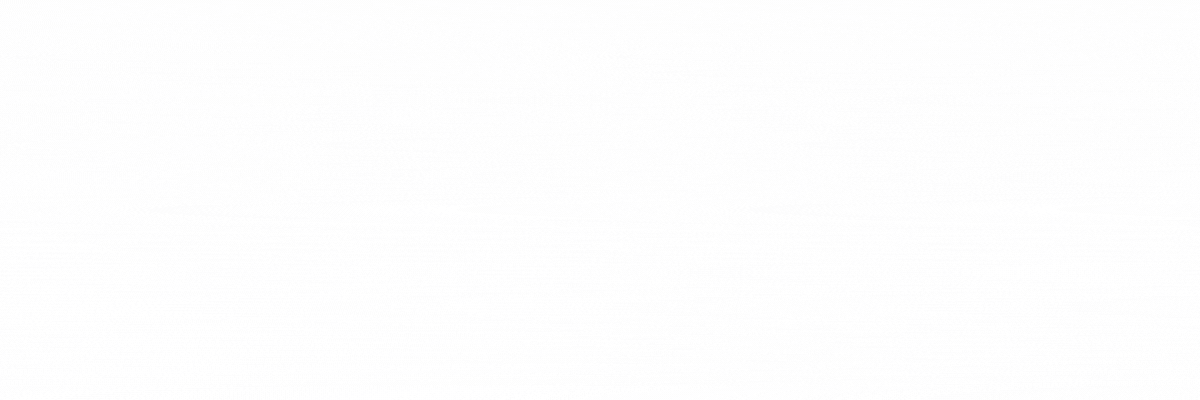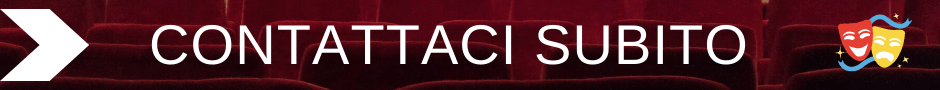di Alceo Lucidi
GROTTAMMARE – Nuovamente cultura ad alto potenziale per la rassegna culturale 2017/2018, organizzata dall’associazione “Blow Up” in collaborazione con l’amministrazione comunale, “Qualunque cosa pensi, pensa il contrario” (frase presa a spunto dal grande art creator britannico Paul Arden, che inviava ad un pensiero diverso, appunto controcorrente, non appiattito sulle convenzioni sociali ed il luoghi comuni per generare valore).
Una giovane ricercatrice e filologa marchigiana, Valentina Appolloni – nata a Tolentino nel 1989, una laurea in Filologia conseguita all’Università di Macerata nel 2013 ed un master in Editoria, giornalismo e management culturale presso l’Università “La Sapienza” di Roma – ha presentato, giovedì 23 novembre, presso la sala Kursaal, il suo primo studio, Silenzi e grida. Munch e Bergman a confronto (Le Ossa editrice), incentrato sul confronto, una vera e propria messa in parallelo, frutto di un’accurata analisi iconografica e stilistica, tra Edvard Munch e Ingmar Bergman.
In realtà, potrebbe dirsi, come rimarca la stessa Appollni, che è solo la provenienza geografica – norvegese Munch e svedese Bergman – e l’età – nato a cavallo tra Otto e Novecento (1863-1944), l’uno, vissuto in pieno XX secolo (1918-2007), l’altro – a separare i due intellettuali, due «giganti» della modernità, come rimarcato dal presentatore della serata Filippo Massacci della “Blow-up”.
I punti di contatto, al contrario, si sprecano: le vite travagliate e segnate dal lutto, l’introspezione psicologica e l’introiezione del dramma umano portati e modello estetico (il passaggio all’espressionismo), l’incapacità di esplicare compiutamente il disagio esistenziale – soprattutto in Bergman – dove l’incomunicabilità esplode nella violenza cieca, nel riso sardonico (quello reiterato e quasi inebetito, fissato in una smorfia di Liv Ullmann – insiste ancora Massacci – nel film probabilmente più caustico, disperato del cineasta svedese, Sussurri e grida del 1972), il senso di mistero tramesso soprattutto dalle figure femminili, la fede e la crisi spirituale, il ricordo della giovinezza perduta.
Ma c’è di più. Sia Munch che Bergman, provenendo entrambi da ambienti protestanti, figli di pastori luterani, si applicano a strappare il velo di ipocrisie e rancori di cui sono intrisi i loro ambienti sociali, fondati su una rigida morale che stritola, sino a ridurli all’impotenza, o appunto, ad una improvvisa distorsione, i sentimenti umani. Tanto da fare pensare ad un’«anima nordica», ossia un sistema di valori, un atteggiamento mentale, un impostazione culturale nel suo complesso.
Attraverso un racconto fatto anche di immagini – proiettate per il pubblico in sala – e partendo da uno dei maggiori rappresentanti del Romanticismo tedesco in pittura (quel Caspar David Friedrich che, con il suo Viandante sul mare di nebbia del 1818, riassumerà il sentimento di un’intera generazione artistico-letteraria di giovani ribelli ed emarginati, impotenti di fronte al corso di un Destino, od una natura come «manifestazione infinita», per i quali si sentono impotenti), si snoda la trattazione della dott.ssa Appolloni che parla espressamente di una sovrapponibilità di situazioni, temi e raffigurazioni tra Munch e Bergman. In fondo – gli fa eco Filippo Massacci – che cosa è il cinema d’autore, quello che conta, se non «una successione di quadri»?
Inger sulla spiaggia (1889), al pari della Ragazza alla finestra (1893) di Munch, allora, potrebbero essere volte, mutatis mutandis, in una delle protagoniste, in angosciosa attesa, delle pellicole Bergman, celate dietro una maschera, quasi nascoste, paralizzate da un dolore inesplicabile, un insondabile male di vivere. Ed il famosissimo Urlo (1893), al centro delle burrascose vicende dei tempi recenti – il quadro venne rubato in pieno giorno dopo una rapina nel 2004 al Museo Munch di Oslo e ritrovato nel 2006 –, venire assorbito nella disperazione, insieme profonda e sorda, dello sguardo stesso del regista di fronte all’assurdità del mondo o nel più noto grido di Harriet Andersson nel già richiamato Sussurri e grida. Lo stesso dicasi, di affinità in affinità, di traccia in traccia, tra il dipinto di Munch Le persone sole (1907-1908) e la solitudine dei due protagonisti in una spiaggia desolata nel film di Bergman Come uno specchio (1961), vincitore dell’Oscar per la migliore regia straniera.
I classici, d’altronde, per stare alle parole di Italo Calvino, sono sempre attuali per la loro forza di rigenerazione. E questo ci basti, pur in tanto fosco pessimismo. In realtà un accorato monito.
I cicli di Blow Up proseguono con il film Il grido di dolore della regista Idrissa Ouedraogo, sull’infanzia difficile del piccolo Moctar trapiantato in Francia, giovedì 30 novembre, sempre alla sala Kursaal, alle 21,15. L’intero programma è disponibile sul sito www.associazioneblowup.it
L’ingresso alle iniziative è gratuito con tessera-abbonamento alla Federazione Italiana Cineforum 2017-2018, rilasciata dall’Associazione Blow Up al costo di 10 euro e che può essere sottoscritta all’ingresso. La tessera F.I.C. consentirà di partecipare liberamente a tutti gli incontri del ricco calendario della rassegna.